31 Mag Impresa culturale? È un mostro di Frankenstein?
L’impresa culturale è fatta di parti che rispondono a logiche diverse.
Una risposta evolutiva alle esigenze di un ambiente complesso.
Nel momento di avvio di una consulenza per un progetto culturale, dopo avere parlato dell’idea, si arriva alla questione chiave: Come coprite i costi? La riposta che spesso ricevo è: Ma noi siamo no profit!
Vi spiego qui perché questa risposta non ha senso.

Illustrazione di Bernie Wrightson
Attività d’impresa e No Profit
Confondere l’economicità di un’attività con il divieto di distribuzione di utili non sarebbe di per sé un problema, se dietro non ci fosse un percorso concettuale che necessita di ridefinizione.
Posso valorizzare tutto quello che voglio: competenze, lavoro volontario, patrimonio immateriale ed esperienza, ma devo avere chiaro quanto mi costa realizzare un’iniziativa. Il che significa aver capito cosa mi serve, quando e per cosa.
Poi posso anche decidere che mi stia bene realizzare, qualche volta e per una ragione specifica, un’iniziativa in perdita; posso ammettere che senza un intervento esterno non riuscirò a coprire i costi; posso giocare d’azzardo e contare su introiti di progetto supportati da una esoterica speranza.
Dichiarare, a volte con incorruttibile orgoglio, che l’anima no profit non ha nulla a che fare con la logica dei rendiconti, non mi mette al sicuro dal fallimento pratico.
Eppure questo atteggiamento ha una lunga consuetudine, che ha cresciuto generazioni di operatori culturali senza mai chiedere loro, se non a consuntivo, di essere imprenditori.
Perché, per molto tempo, ha imperato l’idea che la parola cultura non dovesse condividere nulla con i concetti di impresa, management, entrate ed efficienza.
Le luminose frasi per cui con la cultura non si mangia sono l’inevitabile cascame di queste regole semantiche.
Ma oggi, ecco, si parla di impresa culturale.
L’impresa culturale e la Legge di stabilità 2018
La legge di stabilità 2018 ha previsto per le imprese Culturali e Creative un credito di imposta pari al 30% dei costi di sviluppo.
Siamo in attesa del decreto attuativo che specifichi i costi riconosciuti ai fini dell’agevolazione e le procedure per accedere al credito d’imposta.
Questa novità spinge ad alcune considerazioni sulla natura delle imprese culturali, così come definite a livello istituzionale.
La prima, di natura eminentemente pratica: l’agevolazione ha la forma di un credito d’imposta.
Per “sfruttare” un credito di imposta che la normativa prevede utilizzabile solo in compensazione, l’impresa deve essere un soggetto che alla fine dell’esercizio ha un debito con il fisco.
La compensazione significa che il credito d’imposta va a diminuire il debito fiscale.
Se il debito è zero, non c’è nulla da compensare.
Supponiamo di aver sostenuto costi di sviluppo per 20.000 euro. Il credito d’imposta corrispondente è di 6.000 euro. Se nell’esercizio di competenza ho debiti nei confronti dell’erario per 2.500 euro, il mio risparmio sarà pari ai soli 2.500 euro.
Certo, se sono un ente no profit, con un solo dipendente part time, che si avvale di contributi e volontari e che non svolge attività commerciale e quindi non ha IVA da versare, allora anche quei 2.500 euro mi vanno bene.
Questa lunga premessa non ha un intento polemico nei confronti del legislatore, perché credo che l’opportunità di ridurre del 30% i costi di sviluppo di attività culturali sia un’importante occasione per strategie di medio periodo.
Il problema sta piuttosto nella natura dei possibili beneficiari.

Illustrazione di Bernie Wrightson
The Subsidized Muse
Fino a oggi, nella maggior parte dei casi, la gestione della cultura è avvenuta grazie a soggetti costituiti come enti no profit. Interlocutori privilegiati per l’erogazione di contributi da parte di enti pubblici e fondazioni, con la possibilità di contenere i costi sfuggendo a strette logiche di mercato, con una gestione flessibile e spesso decisamente non manageriale. I soli in grado di gestire la cultura elitaria dei beni culturali, con un’importante ricaduta sulla qualità della vita, ma senza un opportuno mercato che potesse reggerne completamente il prezzo. La Musa Sovvenzionata, la definì Dick Netzer.
Possiamo trovare tutti i difetti possibili a questo sistema:
– una strategia di incentivi che genera inefficienza e che grava sulla collettività in genere (e questo obbliga a legare il prodotto culturale a funzioni sociali, didattiche, sanitarie per giustificarne i costi)
– una deformazione del mercato culturale nel quale concorrono soggetti profit e no profit con strutture di costi completamente diverse
– una occasionalità dell’offerta legata a eventi contingenti o a desiderata di committenti specifici
– una assoluta disattenzione per la sostenibilità nel tempo delle iniziative.
Difetti per i quali ci chiediamo come sia possibile che il sistema continui a funzionare e prosperare. Forse non sono neppure più difetti. Sono elementi ineludibili sia per la natura del servizio da offrire sia per l’ambiente, spesso normativamente trascurato. Tant’è che il sistema procede e produce.
Immaginiamo un teatro, una casa editrice, un piccolo museo.
Soggetti che non siano un ente pubblico o una fondazione, ma che, come la maggior parte dei casi, siano gestiti da associazioni non riconosciute o piccole imprese sociali.
Gli si chiede di rapportarsi con un pubblico pagante, con fornitori, con consulenti fiscali e del lavoro che devono applicare nei loro confronti le stesse regole che applicano alla bottega dello speziale o allo studio associato. Devono rispettare le regole civilistiche per poter mantenere la natura no profit.
E non si può fare altrimenti. Queste sono le regole. E questa è la loro unica possibilità di sopravvivenza: se fossero imprese pure, non ce la farebbero (si è recentemente parlato di Quasi Imprese).
Sono composti con pezzi eterogenei, che la necessità ha reso armonici e che la consuetudine e l’assenza di alternativa tengono insieme.
Resta da capire se dietro questi “corpi assemblati” ci sia la scienza di un professor Frankenstein.
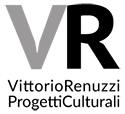

Sorry, the comment form is closed at this time.